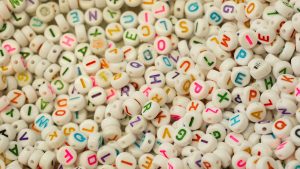Con l’avvento del web 2.0, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione hanno rivoluzionato il modo in cui individui, società e istituzioni si informano, si connettono e interagiscono. Oggi, la nostra quotidianità è segnata da un’iperconnessione pervasiva, in cui dispositivi digitali e piattaforme social plasmano ogni aspetto della vita. Tra queste, TikTok ha rapidamente conquistato la scena globale, diventando uno strumento privilegiato di espressione per milioni di adolescenti della Generazione Z. Attraverso video brevi e challenge virali, i giovani condividono idee, emozioni e creatività, costruendo relazioni e sperimentando la propria identità. Tuttavia, questa nuova forma di interazione presenta anche rischi: le relazioni e la percezione del sé sono sempre più mediate dagli algoritmi, generando talvolta uno scarto tra l’identità reale e quella virtuale.
L’identità giovanile nell’era di TikTok
Nel panorama digitale contemporaneo, gli adolescenti non usano TikTok solo per divertirsi. Attraverso la pubblicazione di foto e video personali, i ragazzi esplorano la propria immagine e costruiscono la propria identità. Dietro ogni video e ogni selfie pubblicato si nasconde una profonda ricerca identitaria. I giovani, infatti, desiderano definire il proprio futuro e conoscersi davvero, ma per farlo hanno bisogno anche dello sguardo degli altri. È proprio il feedback ricevuto — like, commenti, condivisioni — a diventare uno specchio attraverso cui rileggono sé stessi. I contenuti condivisi online influenzano spesso il loro modo di vestirsi, di parlare, di muoversi e persino di ballare. Non si tratta solo di autorappresentazione, TikTok diventa uno spazio dove cercare approvazione, appartenenza e connessione con gruppi che rispecchiano i propri interessi e valori. Esporsi online, quindi, è per molti giovani un modo per rispondere a una domanda cruciale e universale: “Chi sono io?”. E in questa esplorazione, ogni reazione conta.
TikTok conquista la Gen Z: ecco i motivi del successo
TikTok è uno spazio creativo e relazionale dove gli adolescenti costruiscono la propria identità digitale e personale. È diventato per gli adolescenti uno spazio cruciale di costruzione dell’identità. L’iperconnettività offerta dalla piattaforma permette loro di esplorare sé stessi attraverso contenuti condivisi, ispirandosi a ciò che vedono nella rete e alle interazioni con i coetanei. Il bisogno di visibilità e riconoscimento spinge i giovani a pubblicare video creativi per ottenere like e commenti, strumenti che influenzano la percezione e la definizione di sé. La forza di TikTok sta nel suo flusso continuo di contenuti e nella possibilità di modulare la propria immagine in tempo reale. In questo ambiente aperto e partecipativo, ogni utente può esprimersi liberamente, sviluppando relazioni e rafforzando la propria identità sociale.
Inoltre, TikTok è diventato uno spazio per esperti di vari settori che desiderano condividere il proprio talento e conoscenze, affermandosi così anche come un efficace strumento di apprendimento e informazione. La creatività, quindi, non è solo espressione artistica, ma anche mezzo essenziale per crescere e farsi riconoscere. Otre la condivisione dei contenuti, un altro aspetto fondamentale è l’accesso all’informazione. Quest’App cinese consente agli adolescenti di mostrare online le loro relazioni sociali offline. Vivono così un’interazione continua tra reale e virtuale, creando una nuova esperienza umana che il filosofo Luciano Floridi chiama onlife. TikTok svolge il ruolo di palestra della socializzazione in cui l’adolescente crea uno stile riconoscibile cioè il suo marchio personale forte.
Impatti negativi di TikTok sui nativi digitali
Partendo da questi due pensieri, da un lato l’ambiente quotidiano dell’uomo contemporaneo è una infosfera, come dice Luciano Floridi; dall’altro lato, Fabio Pasqualetti, professore di Sociologia dei media digitali e preside della facoltà di Scienze della Comunicazione sociale dell’Università Pontificia Salesiana di Roma, sostiene che «il primo gesto che il ragazzo compie sia quello di mettere mano al suo smartphone, ormai diventato il nostro cordone ombelicale al mondo della rete, il portale di accesso a tutti i servizi digitali, il passe-partout della vita social». Molti adolescenti, immersi nel cyberspazio, costruiscono identità frammentate senza piena consapevolezza di sé. Questa fragilità interiore favorisce fenomeni come il sexting, spesso legato alla ricerca di attenzione e desiderabilità, soprattutto tra le ragazze su TikTok. Accanto al sexting, la “cittadinanza intima” emerge come diritto a scegliere liberamente su sessualità, corpo e identità. In questo contesto, il corpo degli adolescenti diventa protagonista, esposto e scambiato in rete, mentre il selfie e il sexting assumono valore sociale e relazionale, percepiti come pratiche a basso rischio fisico ma ad alto impatto simbolico.
Altro rischio, l’hate speech tra i giovani si diffonde rapidamente sui social come TikTok, colpendo con parole che lasciano segni profondi. Alcuni giovani usano TikTok principalmente per diffondere discorsi d’odio. E l’hate speech si limita ai post, ma mina la salute mentale di chi lo subisce, soprattutto se legato a razza o genere. Le conseguenze possono essere gravi: ansia, depressione e autolesionismo. L’odio online lascia ferite reali. Inoltre, il giornale Le Parisien ha evidenziato che «l’app TikTok, con oltre 15 milioni di utenti in Francia, è diventata il nuovo terreno di caccia dei molestatori», anche se – come ricorda un rapporto di 120 pagine – il fenomeno è presente su tutte le piattaforme. Su TikTok la violenza online assume molte forme: insulti, minacce, diffamazione e furto d’identità. Un fenomeno allarmante che mette a rischio il benessere psicologico dei giovani.
Tra gli effetti negativi dell’uso di TikTok da parte dei giovani, c’è anche l’indebolimento – se non la scomparsa – del valore del dialogo e del confronto all’interno della propria famiglia a causa della dipendenza alla rete. Oggi, i giovani sembrano incapaci di vivere senza l’uso di internet o smartphone, al punto che le interazioni con chi li circonda sembrano perdere di significato, con ciascuno preso dai propri dispositivi. Il risultato è che non c’è più chi offre consigli o correzioni, poiché ognuno pensa di riuscire a fare tutto da solo. Anche il lavoro, così come il tempo libero, sono ormai inseparabili da internet. Per cui, Papa Francesco, nella sua enciclica Fratelli tutti, evidenzia come gli spazi digitali ci rendano spesso insensibili alla vulnerabilità altrui e ostacolino l’introspezione. Secondo il Papa, la “migrazione digitale” ha allontanato le persone dalla famiglia e dai valori culturali e religiosi, spingendole verso una realtà solitaria e autoreferenziale. Questo distacco provoca un senso di sradicamento, pur restando fisicamente nello stesso luogo.
Quando il dialogo familiare o educativo si spezza, i giovani rischiano di finire intrappolati in una spirale di opinioni omogenee, trovando rifugio in bolle virtuali come quelle di TikTok. Qui, le echo chambers amplificano tendenze e idee, ma senza mai stimolare una vera crescita personale. Questa fornisce una crescita sospesa e una conoscenza di sé che resta incompleta. Molti giovani su TikTok coltivano una visione distorta di sé, convinti che la quantità di contenuti condivisi e il numero di like ricevuti definiscano il loro valore. Questa mentalità li spinge verso il narcisismo, isolandoli in una realtà autoreferenziale dove si vedono come il centro del mondo. In altre parole, dietro la questione del narcisismo c’è quella del potere e dell’essere visti. E quel che è ancora peggio, il fenomeno del narcisismo porta all’individualismo.
Quindi, se l’utente di TikTok non è abbastanza vigile, rischia di non vivere una vera relazione con gli altri, ma di cadere in una trappola che lo isola sempre di più, come ha già ricordato Papa Francesco nel suo messaggio per la 53ª Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali. L’uso eccessivo di TikTok sta spingendo alcuni giovani a un progressivo distacco dalla vita sociale, con una riduzione dei contatti reali e un crescente isolamento. Una deriva che porta molti a chiudersi in se stessi, fino a diventare, come ha denunciato Papa Francesco, dei veri e propri “eremiti sociali”.
Un’altra deriva, per molti giovani TikToker, è legata al fatto che diventa sempre più difficile distinguere se siano eccessivamente coinvolti nei contenuti che condividono sui propri profili oppure semplicemente dipendenti dai like e dai commenti ricevuti. Basta una breve disconnessione perché scatti una vera e propria crisi: paura, ansia, senso di esclusione. È il fenomeno noto come FOMO, ovvero la paura di perdersi qualcosa o di non essere aggiornati su ciò che accade intorno. L’uso eccessivo di TikTok sta generando una vera e propria forma di dipendenza tra i giovani, che trascorrono gran parte del tempo incollati allo schermo, anche durante altre attività. Questo comportamento compulsivo può provocare sintomi fisici come mal di testa, vertigini, stanchezza o dolori localizzati. Un fenomeno crescente che solleva serie preoccupazioni sul benessere mentale e fisico delle nuove generazioni.
Il ruolo di educatori e genitori
TikTok è diventato uno spazio centrale per i giovani soprattutto della Generazione Z, cioé dei nativi dititali, che lo utilizzano per comunicare, divertirsi e condividere contenuti. Se usato responsabilmente, può favorire lo sviluppo dell’identità, ma se gestito male può portare a dipendenza e isolamento. Educatori e genitori hanno un ruolo fondamentale nell’insegnare un uso equilibrato della piattaforma, incoraggiando anche interazioni faccia a faccia per un’autentica crescita personale.