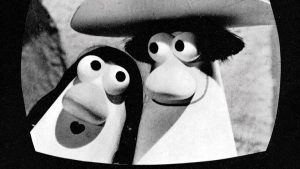Fin dall’origine i musei hanno rappresentato l’affermazione di prestigio personale o collettivo, più che la celebrazione di un bisogno disinteressato di conoscenza. Durante l’Ottocento, i grandi musei europei sono stati strumenti di consolidamento dell’identità nazionale; nel Novecento, sotto i regimi totalitari, hanno assunto connotati propagandistici espliciti e sono stati usati per orientare il consenso e trasmettere valori ideologici. D’altro canto, la cura nella difesa del patrimonio durante le Guerre testimonia il reale valore sociale attribuito ai beni culturali, che in termini assoluti possono essere definiti patrimonio e eredità sociale e culturale.
Tuttavia, il patrimonio culturale esposto nei musei è spesso materia tangibile defunzionalizzata o materia intangibile decontestualizzata dal nucleo del proprio vissuto, complici allestimenti e impianti museografici trattenuti e tradizionali, che faticano a sciogliersi e lanciarsi in iniziative più originali e marcatamente “non neutrali”. La porzione di conoscenza trasmessa dai musei è oggi sufficiente a giustificare macchine complesse e mastodontiche come quelle museali? Provocatoriamente, perché dovrebbe interessarci la romantica e squisitamente elitaria conoscenza racchiusa nei musei? Oggi, più che mai, nel pieno di una trasformazione culturale e sociale, i musei sono chiamati a ridefinire il loro ruolo.
Un futuro che cambia in fretta
“The Future of Museums in Rapidly Changing Communities”: è questa la formula scelta dall’International Council of Museums (Icom) per l’edizione 2025 dell’International Museum Day, la giornata mondiale che ogni 18 maggio, dal 1977, invita a riflettere sul presente e sul futuro delle istituzioni museali. Si tratta di un’occasione globale, che affronta annualmente un ambito specifico. Il tema di quest’anno ci invita a ripensare il ruolo dei musei come attori dinamici e innovativi in una società in continua evoluzione. Ma cosa significa, concretamente, essere un museo nelle comunità in cambiamento?
Viviamo in un tempo segnato da trasformazioni che si evolvono veloci, ma affondano in mutamenti sociali che toccano le radici dell’esser-ci: diseguaglianze crescenti, flussi migratori, polarizzazione del dibattito pubblico, sfide ambientali, tecnologiche ed etiche. In questo scenario, il museo può essere un presidio di civiltà? Ha il coraggio di ergersi come un autorevole punto di riferimento culturale e relazionale? Non basta più conservare e raccontare: oggi i musei sono chiamati a interrogarsi su come “abitano” i luoghi e le relazioni con la società.
Ripensare il ruolo sociale dei musei
Il tema scelto per il 2025 si intreccia con alcuni Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda ONU 2030, che invitano a ripensare il ruolo delle istituzioni culturali come attori chiave nello sviluppo delle comunità. I musei, infatti, possono contribuire alla crescita dei territori promuovendo l’occupazione e l’educazione (SDG 8), sostenendo l’innovazione attraverso la creatività e l’adozione di tecnologie inclusive (SDG 9), nonché agendo come presìdi urbani di resilienza, inclusione e cura del patrimonio (SDG 11). Pertanto, i musei sono soggetti utili a costruire comunità più coese.
Competenze per connettere
In questo contesto, emergono nuove figure professionali, capaci di tenere insieme contenuti e relazioni. Tra queste, il comunicatore museale è forse una delle meno visibili, ma anche una delle più strategiche. Non trasmettono solo informazioni, ma costruiscono relazioni, rendono accessibili narrazioni complesse, promuovono l’inclusione. Nel contesto nazionale la figura del comunicatore museale viene studiata dal Gruppo di Ricerca “Comunicazione museale” del Comitato Italiano dell’Icom, che promuove la conoscenza di questa professione, valorizzandone l’operato e sostenendone il riconoscimento formale.
Essere un ponte tra il museo e le comunità richiede competenze complesse: ascolto, sensibilità interculturale, capacità narrativa e progettuale. Chi si occupa di comunicazione nei musei, oggi, non trasmette soltanto un messaggio, ma lo traduce al fine di interpretare il passato per leggere il presente e educare al futuro.
Un’occasione per ripartire dalle comunità
L’International Museum Day è una soglia. Un’occasione per fermarsi, guardarsi attorno e chiedersi quale ruolo possiamo e vogliamo affidare ai nostri musei. Una risposta possibile sta nel riconoscere il museo come luogo di mediazione: tra culture diverse e tra istituzioni e cittadini. Non più un tempio del sapere, ma uno spazio aperto di dialogo. Un luogo intenzionato a superare il concetto opprimente di “bellezza”, che se continua ad essere elevata quale bandiera del patrimonio culturale, rischia invece di essere condanna di esclusione per tutti i fruitori che intimamente non si sentono in grado di coglierla.
In un tempo che cambia, servono istituzioni che sanno cambiare con le persone. Musei che sappiano ascoltare, prima ancora di parlare. Musei che sappiano essere accessibili, non per trasferire nozioni o “sapere”, ma per educare al “saper essere”.
Il museo può impegnarsi a dare voce a nuove storie, raccontandole da punti di vista plurali. In questo senso, il museo può smettere di essere uno scrigno di meraviglie e diventare uno strumento di amplificazione di democrazia.